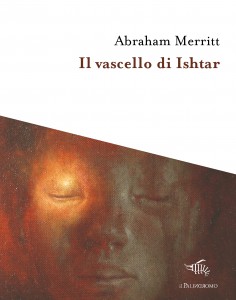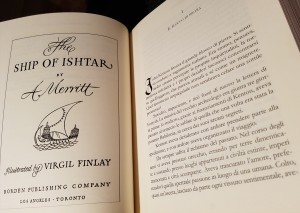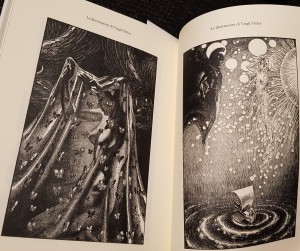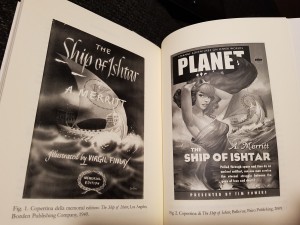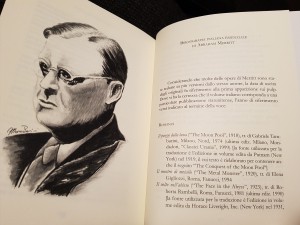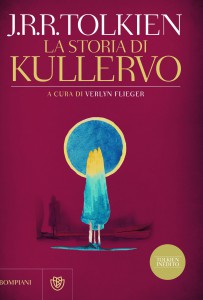Mitica spada di Re Artù, anche chiamata “Caliburn” o “Caliburno” o “Caledwlch”, forgiata sull’isola di Avalon. Erroneamente considerata la spada che Artù estrasse da un’incudine, posta sopra una roccia, e che mediante tale rituale lo avrebbe fatto incoronare e riconoscere quale monarca, è invece una spada che egli acquisì successivamente. Thomas Malory, infatti, nel suo “Storia di Re Artù e dei suoi cavalieri”, racconta di come Artù fu quasi sconfitto, durante un viaggio in compagnia di Merlino, da un forte cavaliere presso una fonte: il cavaliere era un certo Pellinor, che in seguito sarebbe entrato al servizio di Artù come cavaliere della Tavola Rotonda. Dopo essersi curato presso un eremita, Artù si accorse di essere rimasto senza una spada. Preoccupato per l’improvviso disarmo, fu rincuorato da Merlino, che gli disse: «Non importa, non lontano da qui ce n’è una che vi apparterrà, e io so come farvela avere.» Si recarono, pertanto, presso un Lago “vasto e ameno”, dal quale emergeva un braccio rivestito di sciamito bianco e sorreggente una magnifica spada. In quel luogo, ad Artù si avvicinò Lile, la Dama del Lago, reale proprietaria della spada sorretta dal braccio. Artù chiese la spada alla Dama, la quale rispose: «Se mi concederete un dono allorquando ve lo chiederò, sarà vostra.» Dunque Artù, salito su una barchetta, raggiunse il braccio rivestito di sciamito bianco, afferrò la spada, nel suo fodero, e la fece propria, mentre il braccio si inabissava. In seguito, il cavaliere Balin, detto il Selvaggio, nonché Cavaliere delle due spade, estrasse un’altra magica spada, poi appartenuta anche al prode Galahad, da un fodero da cui nessuno riusciva a estrarla, liberandone una gentildonna – messaggera di Dama Lile – che la portava al fianco con suo grande disagio. Questa seconda spada apparteneva, anch’essa, alla Dama del Lago, la quale si recò presso Artù chiedendo quel dono pattuito alla consegna di Excalibur: in particolare, chiedeva la testa di Balin, assassino del di lei fratello, o la testa della messaggera, assassina del di lei padre; o, ancora meglio, la testa di entrambi. Artù non voleva concedere simili doni, che gli avrebbero arrecato disonore, e chiese di poter rendere qualunque altro servigio in alternativa. Mentre ancora temporeggiava con Dama Lile, sopraggiunse Balin, che recise il capo della donna, accusandola di aver compiuto falsità e incantesimi che – tra i tanti misfatti – avevano condotto la madre del cavaliere al rogo. Artù, disonorato dalla condotta di Balin, lo scacciò dal regno e provvide a seppellire Dama Lile con tutti gli onori: tuttavia, ne seppellì il corpo decapitato, poiché la testa fu inviata da Balin ai propri amici in Northumberland, per dimostrare la compiuta vendetta in memoria della madre.
In punto di morte, Artù domandò a Sir Bedivere di gettare Excalibur in mare: Bedivere acconsentì e si allontanò con la spada. Per strada si mise ad osservare “la nobile arma e le pietre preziose che ricoprivano il pomo e l’elsa” e pensò che il gettarla via ne avrebbe fatto derivare solo perdite e danno. Pertanto, la nascose sotto un albero e tornò dal re, che gli chiese cosa avesse visto nel gettarla via. Bedivere rispose: «nient’altro che onde e venti.» Artù capì che Bedivere mentiva e, dopo averlo redarguito, gli domandò nuovamente di gettare la spada in mare. Tuttavia, nuovamente Bedivere nascose la spada e tornò da Artù dicendo di aver visto null’altro che “flutti e ondate nere”. Artù nuovamente si adirò e lo ingiuriò dandogli del fedifrago e traditore e gli ordinò di gettare la spada: infatti, il re era preoccupato dall’avvicinarsi della morte e minacciò di uccidere Bedivere, se non avesse adempiuto all’ordine. Finalmente Bedivere, spaventato dalle minacce, andò a recuperare la spada, là dove l’aveva nascosta, e si recò in riva al mare: “avvolse la cintura intorno all’elsa e la scagliò più lontano che poté. Allora vide un braccio e una mano sorgere dall’acqua, afferrarla stretta, brandirla tre volte e poi inabissarsi con l’arma.” Quando tornò da Artù, per la terza volta, gli disse cosa realmente avesse visto e questi, soddisfatto, si fece aiutare a raggiungere l’imbarcazione che lo avrebbe portato sull’isola di Avalon. In questa storia è possibile riconoscere un parallelo simbolico con le tre negazioni mosse da Pietro a Gesù nella narrazione della Passione.
Excalibur, il cui nome (sostiene sempre Malory, per quanto l’etimo sia incerto) significherebbe “Taglia Acciaio”, sarebbe stata, secondo la leggenda, pressoché invincibile. Eppure, il vero punto di forza di quest’arma era il rispettivo fodero: infatti, chiunque lo cingesse al fianco, per quanto venisse ferito, non avrebbe sanguinato e sarebbe stato quindi invincibile. Infatti, spada e fodero uniti costituirebbero, per le loro prodigiose caratteristiche, sia un invincibile attacco che un’ottima difesa.
Goffredo di Monmouth, nel suo “Historia regum britanniae”, l’opera più celebre sull’Artù storico, menziona la spada Excalibur accanto ad altri due strumenti marziali incredibili, sempre posseduti dal monarca: la lancia Ron e lo scudo Prydwen. La lancia è descritta come «lunga e larga, adatta a fare strage di nemici.» Su detto scudo, invece, sarebbe stata rappresentata l’immagine della Vergine Maria: in tal modo Artù aveva sempre presente nella mente la figura della Madre di Cristo.
Per quanto riguarda l’altra spada di Artù, quella generalmente confusa con Excalibur ed estratta da un’incudine sopra una roccia, si può brevemente osservare come sia un probabile riferimento ad istituti giuridici di origine sassone. Era, infatti, usanza diffusa presso i popoli germanici (che, vale la pena ricordare, nei primi cinque secoli d.C. furono spesso alleati o rivali dei britanni, andando a costituire con essi quel popolo anglo-sassone cui, appunto, si deve parzialmente riferire il ciclo Arturiano) che il figlio di un nobile andasse a combattere, come soldato, nell’esercito di un altro nobile, presso cui così compiva il proprio addestramento senza alcun favoritismo. Successivamente, quando il ragazzo raggiungeva l’età adulta, poteva tornare presso la famiglia d’origine e prendere finalmente posto in essa, magari sostituendo il padre al comando. A tale istituto si aggiunga il cerimoniale delle spade (descritto persino nel “Gesta dei re e degli eroi danesi” da Saxo Grammaticus), consistente nel dissotterramento della celebre e avita spada paterna: è una prova cui il pretendente al trono era tenuto a cimentarsi per dimostrare la propria legittimità, simboleggiante il raggiungimento dell’età adulta e della forza necessaria a combattere con la spada, sia in difesa della stirpe, sia per comandare il popolo. Nelle antiche saghe le armi sono generalmente sepolte nei tumuli: l’estrazione della spada paterna da un’incudine o roccia, in cui era stata conficcata in precedenza, ne è probabilmente una variante. È narrato, a proposito, di come Artù fu educato da mago Merlino e allevato non dal padre, Uther Pendagron, bensì da un altro nobile, Sir Ector (o Hector), e dalla di lui moglie, insieme al figlio di quest’ultimo, fratello di latte per Artù. Il ragazzo in questione aveva nome Kay (o Kaio o Cai o Cei), e altri non è che il celebre Sir Kay, il Siniscalco, altro cavaliere della tavola Rotonda. Morto Uther Pendragon e rimasto senza monarca il regno d’Inghilterra, su consiglio di Merlino, tutti i nobili e gentiluomini d’armi del regno furono convocati, sotto pena di scomunica, dall’Arcivescovo di Canterbury a Londra nel giorno di Natale. Infatti, come Gesù, quella notte, era nato per essere Re del mondo, così il Padre avrebbe concesso il miracolo di far sorgere, quella stessa notte, il Re d’Inghilterra: colui che avrebbe estratto la celebre spada incastonata nell’incudine. Queste sono le parole con cui è descritto il luogo da Malory: “Nel camposanto dietro l’altare maggiore fu vista una grande roccia quadrangolare, simile a un blocco di marmo, che sorreggeva nel mezzo una sorta d’incudine d’acciaio alta un piede in cui era infitta una bella spada. Intorno all’arma una scritta in lettere d’oro diceva – colui che estrarrà questa spada dalla roccia e dall’incudine è il legittimo re di tutta l’inghilterra.” Ebbene, si narra che Artù, ancora giovane, accompagnasse al torneo di Capodanno il patrigno Ector e il fratellastro Kay: quest’ultimo da poco investito cavaliere, nel giorno di Ognissanti. Essendo rimasto senza spada, Kay chiese ad Artù di tornare a prenderla all’alloggio paterno. Giunto in loco, Artù lo trovò serrato e deserto. Per non lasciare senza spada il fratellastro, si recò a estrarre “con uno strappo deciso, ma senza sforzo” la spada al camposanto, lasciato incustodito dai guardiani, recatisi con tutti gli altri alle giostre. Sir Kay capì subito di quale spada si trattasse e provò a investirsi monarca innanzi al padre Ector: ma subito rivelò essere stato Artù a estrarre la spada. La spada fu reinserita nell’incudine: sia Ector che Kay tentarono più volte d’estrarla e nella stessa impresa si cimentarono moltissimi baroni, nobili e cavalieri, più volte, a distanza di giorni o settimane, tanto nel giorno dell’Epifania, quanto a Candelora, a Pasqua e a Pentecoste; l’unico, tuttavia, che riuscì sempre e solo a estrarre la spada senza fatica, tutte le volte che vi provò, fu Artù, che fu pertanto incoronato re d’Inghilterra, per acclamazione del popolo, nel giorno di Pentecoste.
Così, con l’addestramento fuori dalla propria famiglia e l’estrazione della spada per diventare monarca, il mito di Artù si ricollega proprio ai simboli e agli istituti giuridici della realtà di quell’epoca. Uno di quegli infiniti scambi tra mito e realtà così diffusi e cari al ciclo Arturiano.
(Copyrights: Francesco Brandoli)